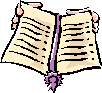|
Le bandiere ombra e l’inquinamento
ambientale
La
sistematica ricerca di trasporti a bassissimo costo spiega la lunga litania di
disastri petroliferi, soprattutto nell'Europa occidentale: Torrey-Canyon nel
1967, Olympic-Bravery, Urquiola e Boehlen nel 1976, Amoco-Cadiz nel 1978, Gino
nel 1979, Tanio nel 1980, Haven nel 1991, Aegean-Sea nel 1992, Braer nel 1993 e
Sea-Empress nel 1996 (anno in cui sono naufragate, in tutto il mondo, 70
petroliere). Ultimo in ordine cronologico, quello della petroliera Erika che,
partita da Dunkerque alla volta di un porto italiano, si è spezzata ed è colata
a picco in seguito a una tempesta
al
largo di Penmarch, il 12 dicembre scorso.
Come già ricordato il
trasporto marittimo mondiale somiglia sempre più a una giungla, in cui regna
una concorrenza spietata. Fino alla fine degli anni 60, era dominato da una
manciata di grandi nazioni che si prendevano carico sia della costruzione delle
navi che del loro utilizzo sotto le proprie bandiere, il che assicurava un buon
grado di sicurezza tecnica e solide garanzie salariali e sociali per i marinai,
vista le difficoltà e i rischi del mestiere. Così, prima della crisi
petrolifera del 1973, le grandi compagnie petrolifere provvedevano da sole alla
produzione del greggio e dei suoi derivati, facendo uso delle loro flotte per
trasportarli fino alle raffinerie. Da allora, però, sono state introdotte nel
settore, per eludere una normativa internazionale vieppiù rigida che però,
paradossalmente, l'Organizzazione marittima internazionale (Omi) e gli stati,
per mancanza di mezzi o di volontà, si sforzavano sempre meno ad applicare due
grosse novità: la massiccia esternalizzazione e la diffusione di bandiere
ombra. L'esternalizzazione risponde a due obiettivi principali: il primo di
carattere finanziario fare abbassare i costi generali della lavorazione del greggio
, il secondo giuridico sfuggire, in caso di trasgressione, ad ogni azione
giudiziaria o sanzione, grazie a una selva di intermediari in un torbido
intreccio di società e attori di ogni sorta. L'Erika costituisce un buon
esempio di questo groviglio economico, giuridico, tecnico e umano: in
ventiquattr'anni ha cambiato sette volte nome, nove volte gestore e cinque
volte bandiera. La nave batteva bandiera maltese, era proprietà di una potente
lobby di armatori greci, con sede a Londra e nel Pireo, che, a quanto pare,
faceva da prestanome ad una grande famiglia napoletana, i Savarese, impegnati
da secoli nel ramo del commercio internazionale.
Gestita da una
società italiana di Ravenna, armata da un mediatore inglese, dotata di un
equipaggio indiano, veniva poi noleggiata per conto di TotalFina, primo gruppo
industriale francese.
Una tale situazione
ha permesso a Thierry Desmarest, presidente di TotalFina che noleggia più di
1.000 navi l'anno di addossare la responsabilità della marea nera all'armatore,
trincerandosi dietro il
diritto internazionale (la convenzione
di Bruxelles del 1969, modificata nel 1992) secondo cui è il proprietario di
una nave a doversi far carico della sua gestione e dei danni derivati da
eventuali inquinamenti. Utilizzando i servizi di Total International Limited,
la sua consociata commerciale con sede nelle Bermuda, e di Total Transport
Corporation, altra consociata che si occupa dei trasporti immatricolata a
Panama, il gruppo si inserisce perfettamente in questa torbida logica di deresponsabilizzazione,
che gli permette di lesinare sulle spese. Mentre Shell, Bp e Exxon avevano
rifiutato i servizi dell'Erika, pienamente al corrente dei rischi che avrebbero
corso (grazie a una banca dati comune), TotalFina non ha esitato a noleggiarla.
Di fronte a una tale
situazione, le autorità nazionali e internazionali avrebbero potuto agire con
forza, se solo ne avessero avuto la volontà politica. Fin dal 1993, in seguito
al naufragio della Braer, il Parlamento europeo esortava la Commissione ad adottare
alcune misure: divieto d'ormeggio nei porti dell'Unione per le petroliere con
più di 15 anni (come avviene negli Stati uniti), adozione di un calendario di
scadenze per vietare l'approdo alle petroliere sprovviste di doppio scafo e
interdizione delle bandiere ombra. Ma, sotto le pressioni della lobby
petrolifera, il consiglio dei ministri dell'Unione ha deciso di rimettersi alle
decisioni dell'Omi.
A livello
internazionale, nel febbraio 1986 è stato adottata, dopo dieci anni di
trattative condotte sotto l'egida della Conferenza delle Nazioni unite per il
commercio e lo sviluppo (Unctad), una convenzione sulle condizioni
d'immatricolazione delle navi, finalizzata a stabilire "un reale legame
tra navi e stati di immatricolazione". Ma il rifiuto di ratificarla da
parte di diversi stati ancora ne blocca l'applicazione. Il Giappone e gli Stati
uniti hanno deciso di agire per conto proprio, fissando misure estremamente
restrittive nei confronti delle navi presenti nelle loro acque territoriali e
riservando il cabotaggio alle loro flotte nazionali.
L'Unione europea, in
conformità con la sua logica ultra-liberista, non ha seguito questo esempio.
Eppure, le compagnie petrolifere hanno sufficienti mezzi finanziari per
impiegare bandiere nazionali, usare navi recenti e sicure (a doppio scafo), o
anche per un rinnovo a medio termine, secondo un calendario da negoziare, delle
loro flotte. Il principio"chi inquina paga" dovrebbe essere
sistematicamente applicato, malgrado i suoi limiti, per scoraggiare a livello
finanziario queste politiche scandalose ad alto rischio ambientale.
Dovrebbe essere
integrato dal principio della corresponsabilità solidale dell'armatore, del
noleggiatore-caricatore, della società di classificazione che ha certificato la
navigabilità della nave, e degli assicuratori. Il settore delle società private
di controllo tecnico e di verifica delle norme necessita di un urgente
risanamento, dopo il pesante errore di valutazione dell' italiano Rina (il Registro navale italiano), un cui
"esperto" aveva esaminato l'Erika il 24 novembre scorso in Sicilia,
autorizzandone in modo compiacente la navigazione.
L'Unione deve anche
intraprendere una lotta risoluta contro le bandiere ombra, soprattutto quelle
europee (Grecia, Cipro e Malta, per esempio), semplicemente vietando l'approdo
alle loro navi e esercitando in modo più energico il diritto che ha lo stato
che ospita il porto di proibire a una nave difettosa di salpare. Ma per far ciò
servono mezzi finanziari e umani. Se, dopo la catastrofe dell’Amoco-Cadiz,
diciotto stati (i quindici dell'Unione europea, più la Norvegia, il Canada e la
Russia) avevano adottato un memorandum proposto dalla Francia, che prevedeva
l'ispezione di almeno il 25% delle navi ormeggiate in ogni porto, la stessa
Francia non si è poi rivelata in grado di rispettare questa quota (ne ha
controllate solo il 18%).
Ciò è dovuto alla
carenza di personale, causata dai tagli di bilancio imposti dall'ideologia del
"sempre meno stato". Così, in Francia ci sono appena 60 ispettori di
sicurezza, quindici volte meno di quanti ce n'erano dieci anni fa, e tre volte
meno di quanti ce ne sono nell'assai più rigoroso Regno unito. Infine, l'Omi
organismo della famiglia delle Nazioni unite, che ha sede a Londra e riunisce
156 stati deve essere potenziato, mediante un rafforzamento dei suoi poteri di
prevenzione e repressione, così come è avvenuto per il traffico aereo. Le
regole del gioco di questo settore, in cui la ricerca di profitti massimi e
immediati permette di provocare, nella più totale impunità, danni di ogni sorta
al patrimonio marittimo mondiale, vanno profondamente cambiate.
|